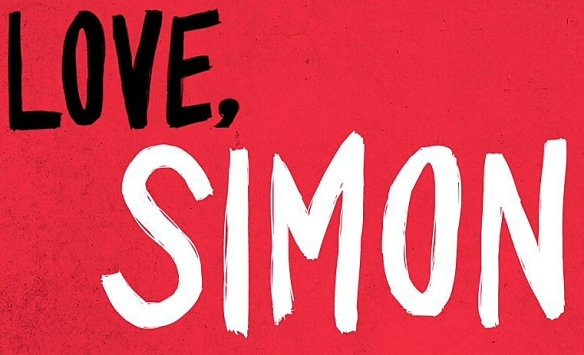Non tutti i film possono essere Your Name, come ho già detto in precedenza, ma che un film d’animazione giapponese porti a casa la seconda posizione in top ten nel suo weekend d’apertura fa sempre piacere. Presentato in anteprima nazionale al Comicon il 1° maggio, Mary e il fiore della strega approda al cinema per una settimana, in un periodo tutto sommato tranquillo per le major, consentendo così un’affluenza discreta per un genere ancora tenuto in una nicchia che ha smesso di aver senso di esistere almeno dai tempi in cui le visualizzazioni dell’ultimo episodio di One Punch Man fecero crashare i server della piattaforma italiana VVVVID. Il film è targato Studio Ponoc, fondato da Hiromasa Yonebayashi, figura di spicco dello studio Ghibli, che ne ha ricevuto (o si è fatto carico, l’opinione generale è ancora discordante) il testimone.
Mary e il fiore della strega è una storia semplice, per ragazzi: liberamente tratto dal romanzo La piccola scopa, di Mary Steward, il film segue le vicende di Mary, ragazzina di circa dieci anni che trascorre le sue giornate ad annoiarsi a morte in un villaggio di campagna di una nazione anglofona non meglio specificata in attesa dell’inizio della scuola, complice il suo essere circondata da soli adulti; un giorno, durante una gita nel bosco, Mary s’imbatte in un fiore luminoso di colore blu, che le dona dei poteri che le consentono di accedere a un universo fantastico a cavallo di una scopa. Mary si ritrova così in una scuola di magia dall’architettura bizzarra, accolta dalla preside che la scambia per una matricola particolarmente promettente a causa dei suoi capelli rossi, del gatto nero che la accompagna e delle sue precoci capacità magiche – dovute però al contatto con fiore, e soprattutto non permanenti. Curiosando nell’ufficio della preside, Mary s’imbatte in un grimorio chiamato ‘Quintessenza della magia’, che diverrà poi un punto focale nella trama. Il mondo in cui la protagonista viene catapultata è una gioia per gli occhi: attingendo un po’ sia all’immaginario Ghibli (ricordiamo tra i riferimenti l’imponenza di Laputa, la fortezza celeste del film omonimo, o lo stile tutto steampunk de Il Castello Errante di Howl), che ad alcuni occidentali (primo fra tutti quello di Harry Potter) o ancora ad altra animazione giapponese recente (vedasi la magnifica scuola di Little Witch Academia dello studio Trigger, nato da una certa cellula della Gainax) riesce a creare un caleidoscopio di colori brillanti, mescolando fondali tradizionali ad animazioni moderne e fluide.
La sequenza di apertura lascia a bocca aperta: un inseguimento magico in piena regola, con una ragazza dai capelli rossi braccata da una varietà spropositata di strane creature – da certi strani uccelli che ricordano un po’ degli pterodattili e dei golem simili a quelli visti in Laputa – per portare in salvo il fiore che poi sarà al centro della storia; la ragazza, però, precipita in una foresta. Quando cade al suolo, il contatto del fiore col terreno fa sì che la foresta diventi rigogliosa – e potremmo citare Nausicaa o Mononoke (a quest’ultimo Yonebayashi stesso ha lavorato).
Che sia un film estremamente derivativo, quasi un omaggio alla vecchia Ghibli che ha deciso di fare un passo indietro rispetto al moderno mondo dell’animazione (criticatissimo da Miyazaki, anche se in forme meno estreme di quelle volute da un certo meme), è lapalissiano e penso anche voluto. Che non sia un’operazione innovativa o coraggiosa pure mi pare chiaro, ma su questo Yonebayashi stesso ha detto : per ora, si sono accontentati di fare un film secondo i crismi e i canoni ereditati dalla Ghibli, senza pretendere di lanciarsi in una sperimentazione che per uno studio letteralmente neonato può essere un rischio troppo alto. Si rimprovera a Yonebayashi di aver fatto un passo indietro dal punto di vista creativo rispetto a Quando c’era Marnie, il film “meno Ghibli” di tutti, e ad Arrietty, sempre diretto da lui; il punto è che di un film bisogna anche valutare le intenzioni. Poiché è letteralmente il primo film del “dopo Miyazaki”, e parliamo comunque di un regista che sinora ha diretto solo adattamenti – quindi ha avuto un materiale da tener presente nella messa in scena artistica, teniamolo a mente – esiste una buona probabilità che si sia concentrato sul voler omaggiare i suoi mentori, tant’è che proprio in questi giorni è uscito il trailer di un nuovo progetto dello Studio Ponoc che sembra voler spaziare molto più di quanto abbia fatto Mary e il fiore della strega.
ATTENZIONE: Il testo a seguire contiene SPOILER